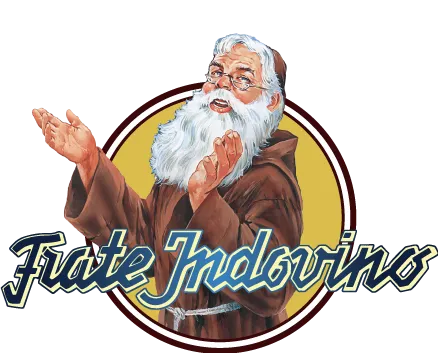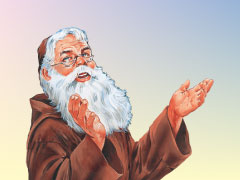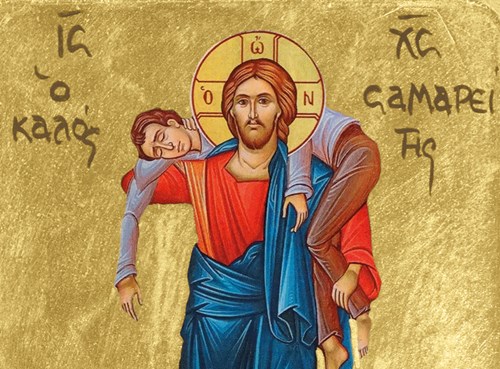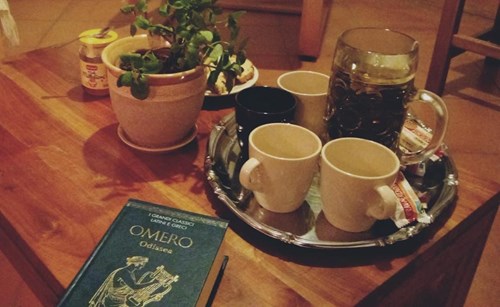A pochi giorni dal Giubileo della Vita Consacrata, non è inutile chiedersi che senso abbiano le parole vita consacrata. Qualche giorno fa, durante una lezione di ecclesiologia, l’insegnante invitava a riflettere sulla realtà della consacrazione, che coinvolge tutti nel battesimo. Tutti siamo consacrati lì.
Ma allora qual è la peculiare nota di quelli che chiamiamo “consacrati”?
Giovanni Paolo II scrive: «La vita consacrata è annuncio di ciò che il Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito compie con il suo amore, la sua bontà, la sua bellezza. Infatti lo stato religioso manifesta l'elevatezza del Regno di Dio sopra tutte le cose terrestri e le sue esigenze supreme; dimostra pure a tutti gli uomini la preminente grandezza della virtù di Cristo regnante e la infinita potenza dello Spirito Santo, mirabilmente operante nella Chiesa. Primo compito della vita consacrata è di rendere visibili le meraviglie che Dio opera nella fragile umanità delle persone chiamate. (…) Così la vita consacrata diviene una delle tracce concrete che la Trinità lascia nella storia, perché gli uomini possano avvertire il fascino e la nostalgia della bellezza divina».
In questo numero 20 dell’esortazione post-sinodale Vita Consecrata (1996) c’è il cuore e il senso della scelta di alcune persone, non perfette, non decorate da meriti, anzi, tutto sommato, più fragili di tante altre, di “dedicare” ogni fibra del proprio tempo, il loro corpo con i suoi desideri e le sue aspirazioni e abitato dallo Spirito, al servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini, seguendo la via del Cristo, il Figlio incarnato del Padre.
E questo modo di vivere, a dire il vero, non è una “religione”. Chiamarsi religiosi è accomodare con un linguaggio molto imperfetto la comprensione che gli altri hanno della vita cristiana, consacrata in questo modo unico. Sosteneva un teologo ortodosso alla fine degli anni ‘80, Alexander Schmemann, che «il cristianesimo è in un senso molto profondo la fine di tutte le religioni». E diceva questo riferendosi alla pagina evangelica della Samaritana, che gli chiedeva spiegazioni sul culto del Dio vero, sul luogo in cui adorare il Dio dei suoi padri. Gesù le risponde che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dinanzi a una domanda sul “culto”, cioè sul tema della religione, Gesù capovolge la prospettiva. La religione serve «quando c’è un muro di separazione tra Dio e l’uomo. Ma Cristo, che è insieme Dio e uomo, ha abbattuto il muro tra l’uomo e Dio. Egli ha inaugurato una vita nuova, non una nuova religione».
Manifestare questo, nella Chiesa cattolica, è un tratto attribuito con un’enfasi spiccata a quei discepoli che la tradizione chiama, per distinguerli da altre forme di consacrazione, i “religiosi” (evitando, da ora in poi, ogni maggiorazione di santità o perfezione di vita a questa parola). E qui, permettetemi di citare (sì, ancora, fino allo sfinimento), quella risposta di Francesco d’Assisi a Masseo, che gli domandava perché tanti lo seguivano, lui che non era bello, non era un uomo di cultura, non era nobile. «Vedi, gli occhi dell'Altissimo Iddio, che vedono in ogni luogo e in ogni cuore, hanno visto che non esiste peccatore più vile, più misero di me sulla terra. Per questo, per attuare il suo grande disegno, Dio ha scelto me, per confondere la nobiltà, la grandezza e la potenza del mondo, affinché si sappia che ogni virtù e ogni bene non provengono dalle creature ma dal Creatore e nessuno possa gloriarsi davanti a Dio (Cor 1,27-31).
Solo a Lui ogni onore e gloria, nei secoli dei secoli».
Perché la vita consacrata? Perché solo a Lui.
Nel Vangelo di Luca, che quest’anno abbiamo ascoltato nella memoria del dottore della Chiesa Teresa di Gesù Bambino, alcuni discepoli aiutano a tracciare, e lo fanno, senza saperlo, con le loro titubanze, il profilo del discepolo. Le parole di Cristo riguardano ogni forma di consacrazione, è chiaro. Ma possiamo riascoltarle per quelle persone che, attraverso i voti, non dividono il cuore, per condividerlo tutto a tutti.
Al primo di questi, il più sfacciato, che gli dice “Seguirò te, ovunque vai, non importa quanto sia lontano”, Gesù risponde che mentre le volpi hanno tane e gli uccelli nidi, il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo. Forse, questa strana risposta di Gesù, rivela una tentazione, che potremmo chiamare la tentazione “della tana”. La vita religiosa non è una fuga dal mondo, non è “accasarsi”, ma riconoscere la nostra casa in Cristo. È come se dicesse: Non deve importarti tanto dove vai con me, ma che sei con me. E puoi non avere una casa, se sono io la tua Persona. Quello che Gesù risponde anche alla Samaritana: non dove, ma chi. La casa sicura, tiepida, non è nei termini del contratto di un consacrato (la destinazione, tanto, si sa, è Gerusalemme dove ognuno celebrerà la Pasqua). La vita cristiana “espone”, perché non ha a che fare con la sicurezza individuale, ma con la salvezza del mondo a cui Cristo è mandato, e a cui Cristo manda i suoi.
Al secondo di questi, il più malinconico, che gli dice “Prima però lascia che io seppellisca mio padre”, Gesù risponde “Lascia i morti ai morti, allontanati da lì e annuncia il regno di Dio”. La tentazione - come mi piace chiamarla - del “prima però” (sono due, le tentazioni di questo tipo). Silvano Fausti usa un’immagine chiarissima per spiegare a cosa spinge la vita del Vangelo: «Chi non esce dalla madre, non nasce». Cristo è il prima di tutto. Cercate prima di tutto il regno dei cieli, tutto il resto verrà dopo e a questo è ordinato. Prima delle creature, il Creatore. Il Cantico di Francesco, che quest’anno abbiamo rievocato di continuo, è l’antidoto a ogni malinconia, perché celebra la gioia di lodare nella fragilità della creazione, la bellezza immortale del Creatore. I consacrati indivisi ricordano a tutti, con la loro vita fragile e imperfetta, che siamo destinati a Lui, che solo in Lui ci in-sempriamo.
Al terzo dei discepoli, il più “giudizioso”, che gli dice “Prima però lascia che mi congedi da quelli di casa mia”, Gesù risponde che chi guarda indietro, non è adatto per il regno di Dio. Adatto, letteralmente “messo bene”. È la seconda tentazione del “prima però”. Il giudizioso è quello che ritiene che prima di seguire Cristo, deve “darsi una sistemata”, risolvere le cose. Ma questo è solo un inganno, un trucco. La religione, vissuta come la pretesa di scavalcare il dramma della nostra mediocrità, e auto-meritarsi un posto nel regno di Dio. Vi ricordate quella canzone dei Nirvana, Come as you are? Vieni come sei. Parole che, in modo nuovo, Cristo rivolge al suo discepolo giudizioso, l’invito a seguirlo senza infingimenti: vieni come viene un amico. Per essere ricomposto nella sua originaria unità e bellezza, per essere indiviso, il cuore spezzato dell’uomo ha bisogno dello sguardo di Dio, che ha chiamato gli uomini suoi amici. A volte qualcuno incontra i frati e chiede preghiere, premettendo frasi come: Voi che siete amici di Dio, come a dire, voi che siete “più vicini a Lui”… Non ci vuole molto a capire che non è sempre vero che siamo più vicini a Dio, ma è sempre vero che la vita consacrata vive di una familiarità quotidiana con il cielo e che questa familiarità il consacrato la gusta nelle relazioni con i fratelli, a cominciare dai più poveri, nei quali vede il volto di Dio. Anni fa, un frate, ringraziando per gli auguri di buon compleanno, diceva: «Rendo grazie a Dio per il dono di essere con-sacrato, cioè per il fatto che la mia vita è resa sacra e bella con voi».
Quel santo distacco che il Signore chiede ai discepoli che mettono mano all’aratro non è freddezza ma libertà, non solo verso le cose o le persone, ma anche verso se stessi: Egli chiede il coraggio di non fissarsi sulla propria storia, sul proprio passato, al punto da renderlo l’elefante nella stanza, l’obiezione contro il futuro che Dio dona e finire col rendere la propria vita un habitat non compatibile con la vita degli altri.
Se, invece, il “consacrato” esce dalla sua tana e si mette per via, piccolo malconcio e pieno di speranza come sono i figli di Dio, se lascia la logica del “prima però” e si fida più del futuro di Dio che degli scheletri del suo armadio, allora il presente sarà un giubileo perenne, anche i suoi naufragi saranno allegri, e con questa gioia sarà come quell’albero che a tutti offre riparo (Mt 13,32).