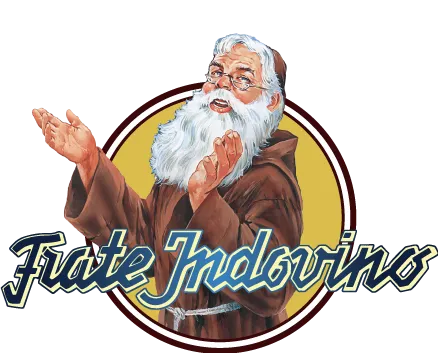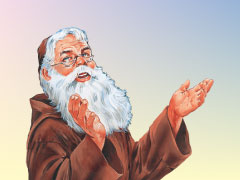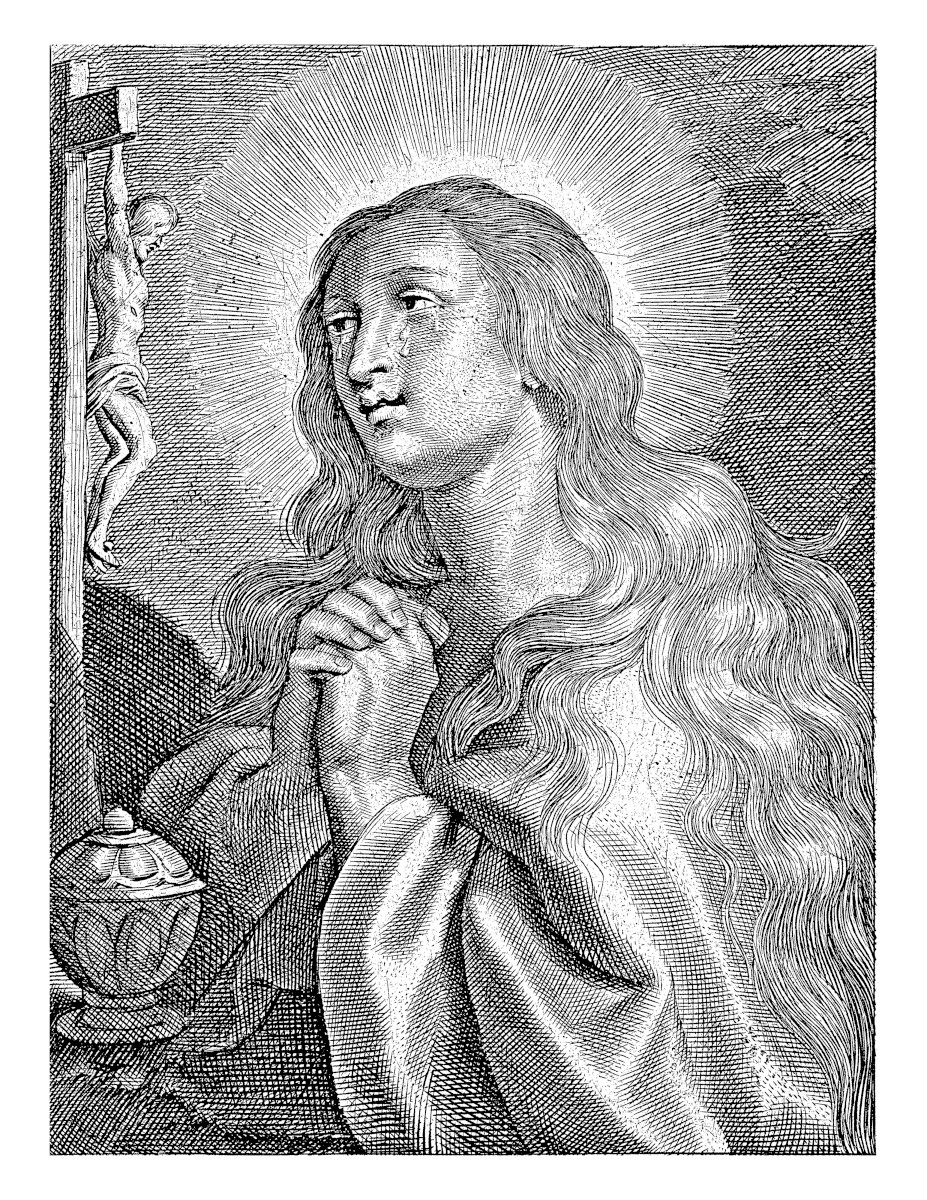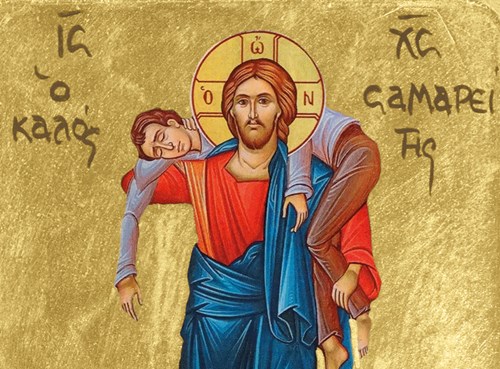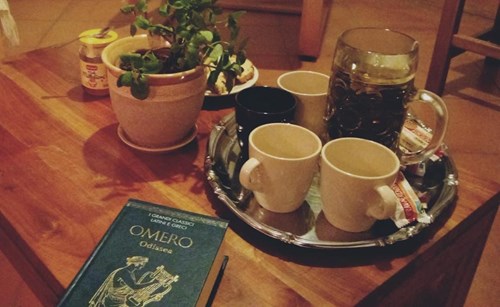I cappuccini sulle tracce di Maria di Magdala

Intorno alla fine degli anni ‘60 del XVI secolo, alcuni cappuccini si legarono con una forte devozione a Maria Maddalena, tanto da essere passati alla storia come i “Maddaleniti” o le “Maddalene”. Strano per degli uomini barbuti? Eppure, no.
Questi fratelli desideravano vivere «qualcosa di più» (con queste parole si esprimono gli storiografi), perché riconoscevano nella prima degli apostoli, un modo francescano-cappuccino di cercare, amare e testimoniare il Vangelo sopra ogni cosa: con i nostri affetti.
Maria di Magdala aveva vissuto il di più: il di più dell’eremo, cioè la fraternità; il di più della fraternità, cioè l’annuncio; il di più dell’annuncio, cioè l’amore alla divinoumanità di Gesù Cristo.
Eppure, le cose non filarono lisce come si sperava!
Vediamone la storia, aiutati dalle nostre fonti.
Al compleanno dei cinquant’anni dell’ordine dei frati cappuccini, inizialmente denominati “frati della vita eremitica”, le Costituzioni che ispiravano la vita dei nostri fratelli erano quelle promulgate nel 1536, attraverso la revisione del 1575. Eppure, tra i fratelli si cominciò a manifestare una certa nostalgia delle origini contemplative dei primissimi di noi.
Durante il governo del vicario generale Girolamo da Montefiore Conca (1575-81) - e a dire il vero lui stesso l’aveva incoraggiata - nella provincia romana e oltre i suoi confini era germogliata una congregazione segreta (o meglio silenziosa) di fratelli che erano soprannominati «Maddalene» o «Maddaleniti», perché il sogno era quello di lasciarsi conformare a Cristo per la via innamorata di Maria Maddalena, modello dei penitenti (da I frati cappuccini, a cura di Costanzo Cargnoni, vol. I, 44).
Questi frati erano infiammati da quella che, con una parola un po’ antica, le fonti chiamano un desiderio di perfezione: si accordavano sullo stesso diapason dei desideri, «per fare qualche cosa di più dell’ordinario» contemplando la vita di preghiera di Maddalena, «stabilendo privatamente alcuni avvertimenti da osservare, e istituendo per sé particolari superiori». E poiché non c’è nulla di segreto che poi non venga alla luce, per quanto fossero discreti, questi fratelli fecero scuola e furono seguiti in molte province. «E il generale non lo impedì ma anzi fu edificato dal vedere tanta buona volontà e prontezza a fare bene nella vita religiosa. Ma i padri del seguente capitolo generale con prudenza, considerando che ciò avrebbe potuto creare degli inconvenienti e che le ordinazioni di questa nuova congregazione non erano rilevanti, poiché la vita comune abbraccia tutto quello che è giovevole a camminare nella perfezione, vietarono questo tentativo come qualcosa di molto pericoloso e di pochissimo o nessun frutto» (Monumenta Historica Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum VI, 352). La preoccupazione, forse eccessiva, dei fratelli ministri era di tenere unita la fraternità, evitando che lo zelo, per quanto lodevole, di alcuni potesse generare divisioni e derive settarie.
L’Archivio Vaticano ci restituisce una lettera di fra Natanaele da Pontoise, della provincia di Parigi (datata 24 luglio 1595), che getta un’importante luce sui risvolti di quell’incessante tensione di riforma, che non ha mai smesso di animare il desiderio dei cappuccini più solerti, e che sembra intercettare quegli ideali della riforma dei Maddaleniti tentata vent’anni prima. Natanaele chiedeva al papa Clemente VIII (in forma segreta perché segregato dai suoi stessi fratelli) di poter lasciare la comunità e vivere in un piccolo e povero convento, nell’osservanza più stretta della regola, soprattutto chiedendo alcuni “privilegi” (che, in verità, erano misure utili al suo proposito): vivere in una casa povera, nella sobrietà dell’abito e nella frugalità dei pasti, nella diligente perseveranza della preghiera e nella riscoperta (che è di ogni epoca,) del silenzio interiore ed esteriore. Il suo progetto di vita era destinato a recuperare il lavoro manuale e l’elemosina “di sporta in sporta”, oltre che «di poter accettare altri frati – dodici o più – alla sua riforma e di dipendere direttamente dal generale». (I frati cappuccini, IV, 115-66).
A preparare il terreno per questi slanci di riforma nella riforma, lo stesso fra Girolamo Pratelli da Montefiore (1575-1581), che nella lettera “Alli divoti lettori”, presenta ai fratelli un’operetta (mai portata a compimento) intitolata Vite di alcuni frati cappuccini. Leggiamo così, dalla sua penna: «Benché io sapessi il padre frate Mario da Mercato Saraceno di buona memoria (come anco prima di me degnamente fu vicario generale della nostra congregazione) aver bellissimo stile tessuta un’istoria nella quale racconta l’origine e progresso di essa congregazione sino a questi nostri tempi, non di meno perché il detto padre non s’estende se non in poche cose a narrar la vita e fatti de’ frati particolari [...] ho pensato non essere superfluo tal’impresa di scrivere le cose più notabili de’ frati particolari». Il suo intento, stando alle fonti che ho voluto rileggere, era quello di riproporre una lettura dei primissimi passi dei frati della vita eremitica, e in particolare di «alcuni padri più antichi», che a lui sembravano importanti memorie da tenere vicino al cuore. Scrivendo a un altro frate, troviamo conferma di questo: confida a fra Bernardino Cioli da Colpetrazzo, che tali letture potessero essere «di grand’utilità, e credo che se a Dio piacerà che si legga tra Frati, come è animo mio si faccia, farà grandissimo frutto e aprirà le menti, e darà grand’animo a quelli che sono inchinati alla pura e vera Osservanza della Regola».
Lo scopo di Girolamo Pratelli da Montefiore è quello di mettere nel cuore dei suoi frati il desiderio di vivere l’Osservanza della Regola, la povertà in primo luogo, nello stesso solco che avevano tracciato quei «molti santi frati» i quali avevano dato inizio alla “riforma cappuccina”. Poiché «vedendo che la memoria di tali cose andava mancando non senza danno dei posteri, pensai per la gloria di Dio (dal quale procede ogni bene) e per utile di tutti i nostri frati presenti e futuri, raccogliere e far mettere in scritto le cose più segnalate delle quali io potessi aver probabile notizia, tanto la santità dei costumi, come circa i miracoli dei nostri frati già passati da questa vita, acciò dalla santità dei costumi li frati potessimo conoscere come in uno specchio la pura osservanza della nostra Regola e la vera vita spirituale, quale dovevano tenere».
Come mi è capitato di leggere da qualche parte recentemente, Gustav Mahler aveva un’espressione molto efficace per descrivere ciò che fra Girolamo intendeva suggerire: «La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri». Per quanto incompreso, possiamo credere che si trattasse di questo.
Incompreso al punto che, durante il Capitolo generale del 1581, ad un anno di distanza dalla pubblicazione della Divota Historia di Bernardino Cioli da Colpetrazzo, al Vicario generale veniva tolto il diritto di voce passiva e attiva in capitolo, «perché si trovò che voleva fare una riforma, i cui frati chiamava maddaleniti, e ciò faceva con buonissimo zelo, e fine, perciò egli sopportò pazientemente il tutto, né mai si volse scusare». Girolamo, dunque, per quanto corretto dai suoi fratelli, non aveva rinunciato al suo sogno.
Le nostre fonti chiosano che quella dei maddaleniti è stata una vera e propria “crisi” al culmine di tensioni che si accumulavano già a partire da precedenti governi dell’ordine, e in particolare dal governo di Eusebio Fardini da Ancona (1552-1558) e da quello del celebre storiografo Mario da Mercato Saraceno (1567-1571).
Nella sua Historia Capucina, Mattia Bellintani da Salò, traccia un giudizio sul governo di quest’ultimo, e ci presenta il quadro evolutivo della “riforma”, forse lasciandosi andare a qualche commento di troppo (se non è faticoso per il lettore, riporterei le sue parole originali): «Egli – scrive il Bellintani – nel suo governo, si come era di tal natura, fu piacevole e benigno, più forse di quello che al’hora havea bisogno la Religione, la quale crescendo in moltitudine, havea bisogno di freno, perché la moltitudine et massime di giovani facilmente scorre – se non è frenata – nelle rilassationi. S’era già cominciato a lasciarsi alcuni luoghi, i quali erano lontani dalle città et fabbricarne de più vicini, il che seguito si è poi man mano con alcuni altri, perché crescendo i frati era difficile portar per tanti la limosina a spalla; non si potevano havere per gli infermi i medici, né commodamente se gli potevano fare le convenienti provisioni. Né il tener gli hospitji nelle città in rimedio della lontananza de luoghi era stimato bene».
Come anche accadde al piccolo numero dei fratelli della prima ora, quelli che furono con Francesco, anche qui adattamenti storicamente inevitabili delle Costituzioni, generarono una riflessione sotterranea e rimisero in moto alcuni desideri di “ritorno alle origini” che, per quanto soffocati, sono in ogni tempo un pungolo per ogni fratello religioso a vivere della radice sempre umida e creativa del carisma. Ed è a questi fermenti che dobbiamo, tra le altre, la sventurata riformella dei Maddaleniti.