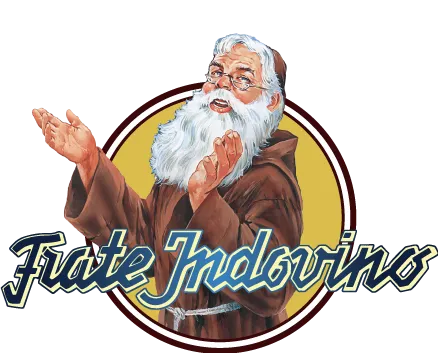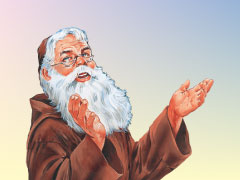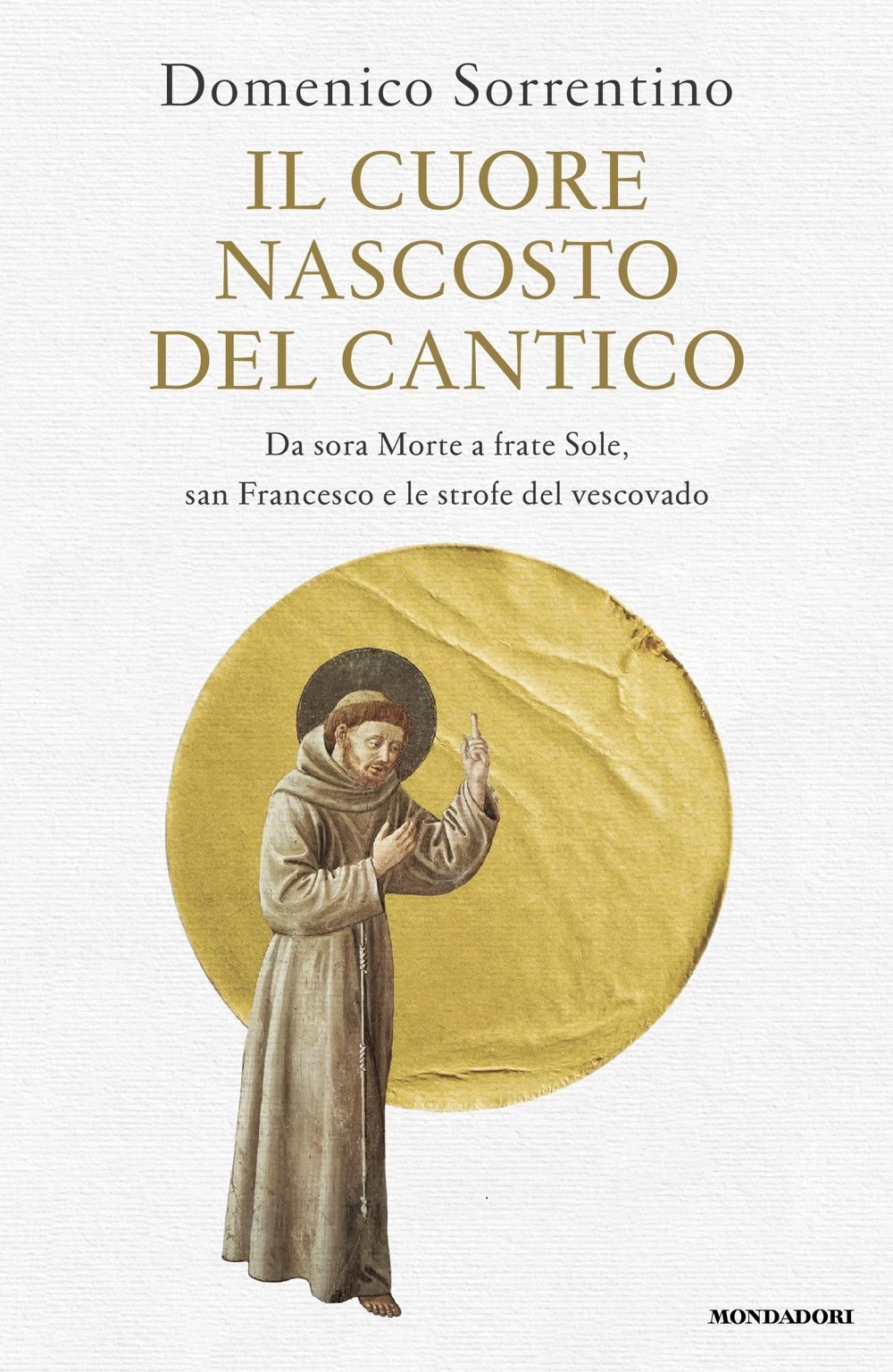
Nel suo ultimo libro dedicato al Cantico di Frate Sole, Il cuore nascosto del Cantico (Mondadori, 2025) monsignor Domenico Sorrentino scrive: L’eucaristia è il mistero in cui converge tutta la vita cristiana. (…) Un pezzo di pane che dice presenza. Presenza di Cristo. «Presenza reale», scolpisce la fede, sfidando la ragione. Francesco di questa presenza vive.
Cos’ha a che fare questo affondo sull’eucaristia con il Cantico delle creature?
Il vescovo di Assisi continua: Come si sente riscaldato e illuminato dal raggio di sole, così [Francesco] sente il «planare» quotidiano del Dio eucaristico sugli altari del mondo.
Nel dirci questo, il vescovo Domenico insegna che Francesco è stato un uomo che, suggellando la sua lode del Dio Altissimo insieme con tutte le creature e in-fine persino con la morte il dolore e il perdono, è divenuto un vero e proprio sacerdote del creato, secondo il cuore e il piano di Dio. Francesco non si è appropriato della creazione, non è lui il punto di riferimento dominatore delle creature che esistono, Francesco sa chi è Dio e chi è Francesco: è un uomo già pieno di gratitudine. Non si separa dalla creazione come se non vi appartenesse e, perciò, ne potesse usare a suo piacimento. Con la sua lode, a cui associa le creature e per le quali “rende grazie”, Francesco fa passare il mondo fra le sue mani non per appropriarsene, sine proprio!, ma per restituirlo al Donatore.
Questo è quello che fa un sacerdote del creato. Francesco riconosce nelle cose del mondo la loro voce personale, la loro - potremmo chiamarla - “ciascunità”. Il povero di Assisi non domina la natura come un padrone, ma la riconduce all’unico Dominus, ascoltandola e riconoscendola come opera del Padre: ciascuna delle creature ha il suo primo riferimento a Dio e, solo dopo, all’uomo. Nella Basilica Inferiore, in uno degli affreschi della navata, Francesco (che era alto poco più di un metro) “parla” agli uccelli e ha la stessa statura di una quercia! Francesco sa di non essere dominus (neppure con la d minuscola).
Perché, dunque, il vescovo Domenico sul finire della sua lettura del Cantico offre ai lettori una ricapitolazione di questo inno di lode nell’eucaristia? Nell’eucaristia Francesco riconosce di ricevere da Dio, per le mani dei sacerdoti, il dono del pane e del vino trasformati nel corpo e nel sangue del Signore e ri-offerti al Padre. Secondo questa stessa dinamica di dono e offerta, anche quando il santo di Assisi dialoga con le creature qualche tempo dopo il passaggio della Verna (e cioè dopo che il Cristo si è manifestato anche nella sua carne), Francesco restituisce con gratitudine a Dio il sole, la luna, le stelle, il vento, la terra, il perdono, la morte, il suo stesso corpo nudo (tra le due spogliazioni della sua vita), perché appartengono a Dio Padre, hanno una sacralità perché di Lui portano significazione.
L’uomo, rispetto al creato, può scegliere fra due strade: piegarlo al suo potere mortifero e volgerlo verso il suo interesse, oppure condurlo alla comunione con Dio, e santificarlo. La conversione ecologica - scrive ancora il vescovo Domenico - suppone una conversione radicale dello sguardo: da funzionale a contemplativo. E questo sguardo libero alimenta la lode. Potremmo dirla ancora più efficacemente con le parole di S. Carlo Acutis: se la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità - ovvero la beatitudine - è lo sguardo rivolto a Dio. La conversione è un semplice movimento degli occhi! E pensare che gli occhi di Francesco, all’epoca della composizione del Cantico, non ci vedevano più.
Ma il Cantico, nella visione del vescovo Domenico, è molto più di questo! Per apprezzarne il potenziale di stupore, l’attuale pastore di Assisi successore di Guido, propone di rileggere il Cantico dalle ultime due strofe, che ne rivelano il segreto.
Queste due strofe, o lasse (come sarebbe meglio chiamarle), sarebbero state scritte da Francesco nel luogo del vescovado di Assisi.
Questa interpretazione, non altrimenti documentata che da qualche sparuto riferimento nelle fonti, giocherebbe a favore della linearità del tutto: il perdono evoca quello che si scambiano vescovo e podestà nello spiazzo interno al palazzo vescovile, il dolore sopportato è quello di Francesco sia nel penultimo che nell’ultimo anno, la morte «sorella» è quella che egli sente avvicinarsi nell’ultima degenza a casa del vescovo.
È una storia un po’ marginale, quella del rapporto di queste strofe con il vescovado, complice quello che Sorrentino chiama il fattore X, ovvero una certa “marginalizzazione” del ruolo del vescovo nelle biografie francescane, specie dopo il passaggio dall’intuizione della fraternitas all’istituzione dell’ordine francescano. Ma questa è una pagina della storia delle fonti che qui non è così importante approfondire.
Ciò che, invece, agli occhi appassionati del vescovo Domenico non può essere semplicemente “rimosso” è, da una parte, l’amicizia e l’atteggiamento convintamente filiale che Francesco aveva verso il vescovo Guido II (del quale era un diacono), dall’altra, la cura dello stesso Guido per quel figlio, Francesco, che il nostro autore immagina come indubitabile.
Suggestiva l’immagine del Cantico che monsignor Domenico Sorrentino evoca, definendolo la colonna sonora del Testamento. E questo tanto è più significativo quanto più ci inoltriamo nella lettura a partire dalle ultime due strofe sul perdono, il dolore e la morte, e cioè riguardando tutto dallo stesso mistero pasquale di Cristo sul Golgota, a cui Francesco a quel punto della sua vita era unito in modo misterioso e quasi speculare.
Solo gli occhi di chi perdona, anche a costo del proprio sangue, e di chi abbraccia sorella morte come avamposto della Vita (quella vera ed eterna), cioè chi onora la sua dignità soprannaturale, riesce a contemplare e benedire il Dio della Creazione naturale: l’Eden perduto… dentro gli occhi di un uomo sofferente. Sofferente della relazione con il padre Pietro, sofferente del suo corpo infragilito dalle infermità, sofferente della relazione con i suoi fratelli, sofferente dell’Amore non amato del suo Signore Altissimo. Quando il vescovo Domenico indugia sul modo in cui Francesco vive la sua afflizione, si spinge a una fugace stilettata ai maestri del pessimismo, o come li chiama lui “i Leopardi e gli Schopenhauer”, per dire la ben diversa attitudine di Francesco che nella notte della sua prostrazione, canta i suoi “laudato sie” come una cascata di beatitudini. Ma a difesa di Leopardi mi permetto di dire che il canto della sua lenta ginestra è stata proprio la prova che, come Francesco, anche Leopardi non poteva essere stato un pessimista. I pessimisti, infatti, non cantano mai!
Rileggere tutte le cose, fin dalle prime che furono “create”, alla luce delle cose ultime, dall’omega all’alfa, e cioè a partire dalla nostra destinazione nell’eternità in cui saremo pienamente figli nel Figlio, è un metodo sempre fruttuoso nell’esperienza della Chiesa. Le cose si comprendono meglio risalendo “dalla fine”. E così vale anche per questa interpretazione del Cantico.
Francesco ha voluto seguire le orme del Figlio di Dio in uno stato perenne di conversione, approntando tutta la sua vita a quella del Signore, Gesù, primogenito di molti fratelli (Rm 8,29): questo è stata la sua regola. E gli ultimi eventi della sua esistenza, che lo hanno reso così somigliante al Cristo di San Damiano, ne sono una attestazione. Francesco vede ormai le cose come le vede lo sguardo dello Spirito Santo, con occhi di colomba, che finalmente, dopo il diluvio, si posano sulle cose create con pace, cioè senza dominio.
Questo è anche lo stile in cui il vescovo Domenico ha approcciato il mistero del Cantico, dono quasi miracoloso fatto alla letteratura mistica di tutti i tempi, e forse ancora inedito in alcuni suoi aspetti. Il vescovo di Assisi resta sulla soglia dell’antico vescovado - che recenti lavori di scavo stanno provando a restituire alla luce, in modo umile, a tratti poetico, ma di una poesia non ingenua. Un saggio didascalico che sbircia nella storia della composizione delle ultime battute del Cantico in-verso di Francesco, immaginando di riparare alcune lacune del racconto delle fonti, nella prospettiva di un Guido dei nostri tempi, tempi di tecnologie senza corpo, di ecologie senza lode e di fratelli senza pace.