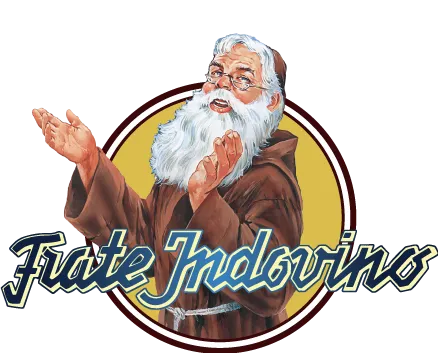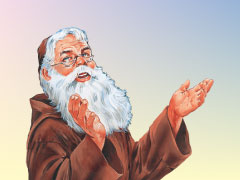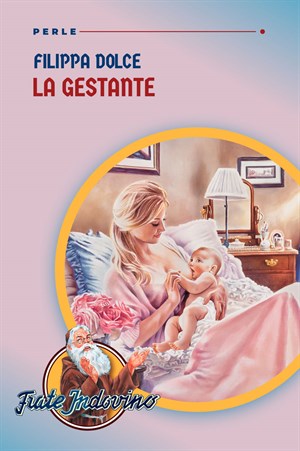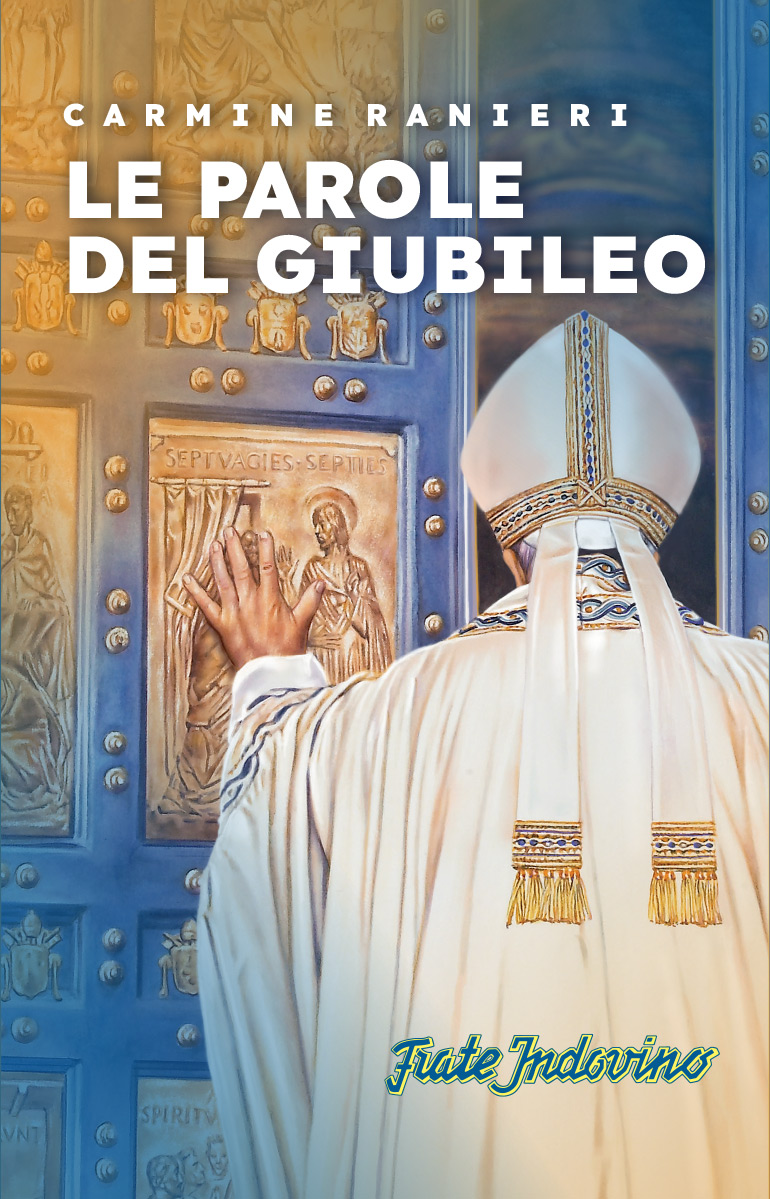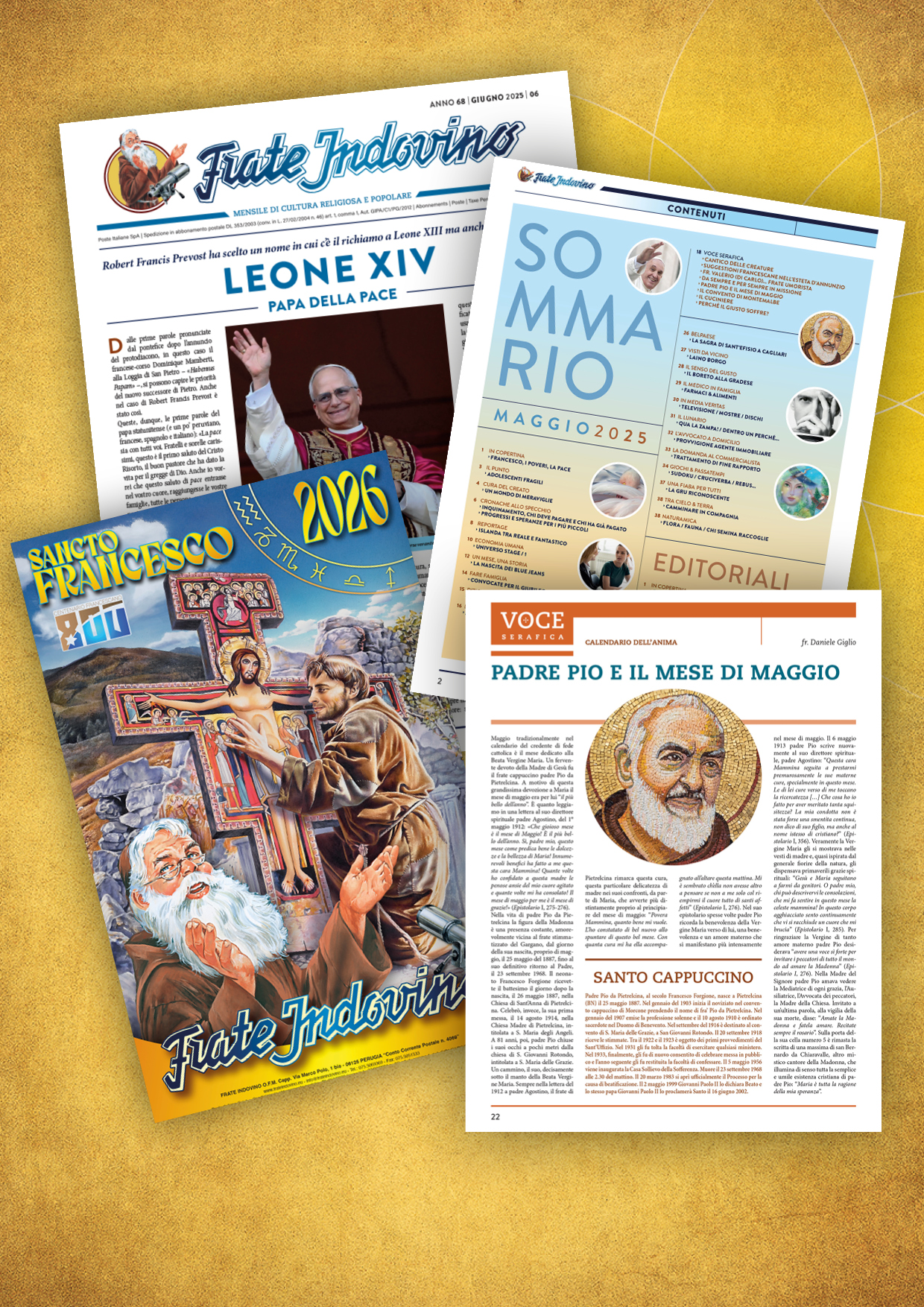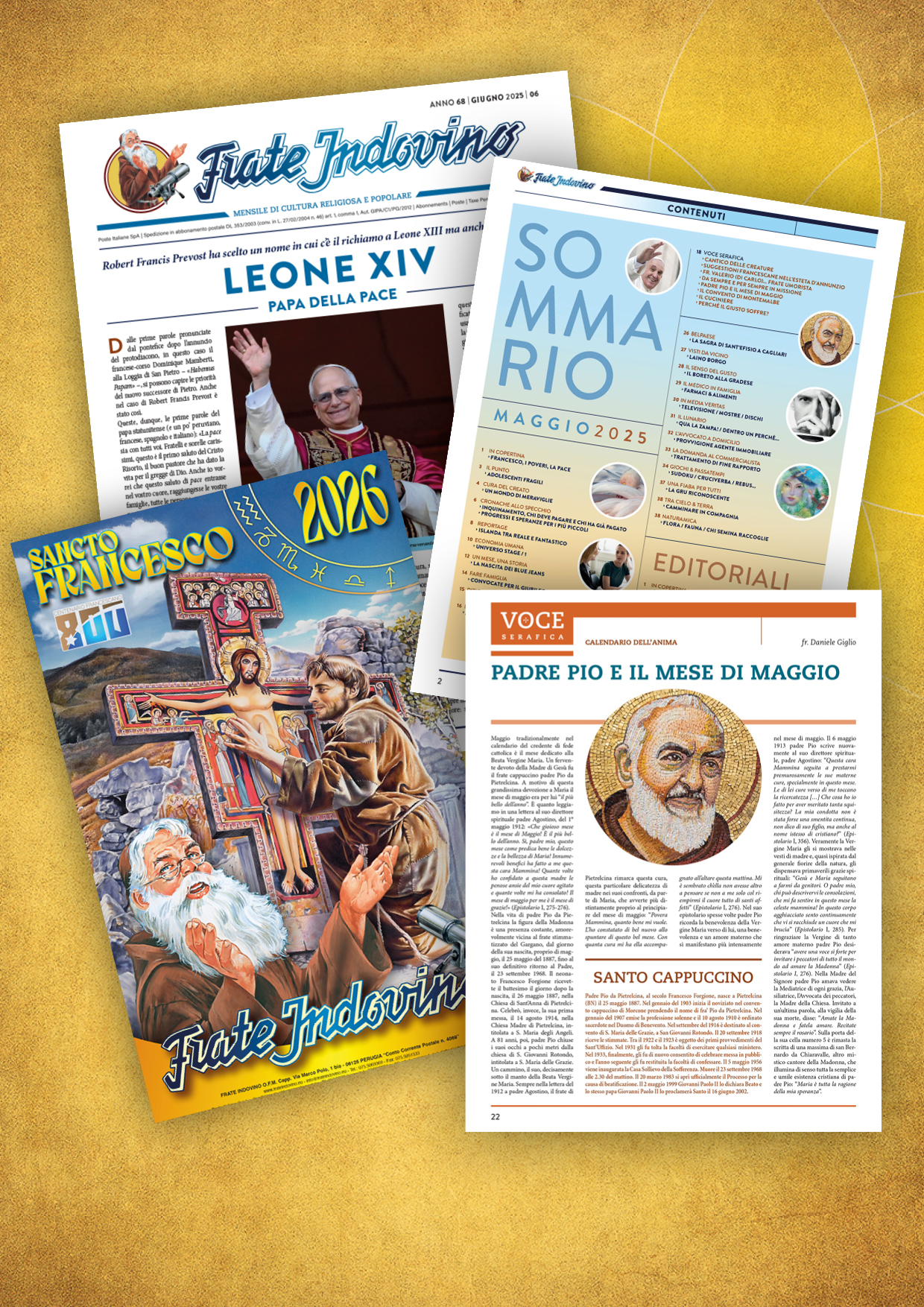C’era una volta il pellegrino. Partiva scalzo o con sandali consumati, una bisaccia in spalla, una croce nel cuore e sulle labbra il nome di Cristo. Camminava giorni, mesi, talvolta anni, senza mappa né albergo, fidandosi della Provvidenza e dell’ospitalità dei monasteri. Il suo viaggio era devozione, penitenza, sete di vedere coi propri occhi i luoghi santi.
Non solo Roma e Gerusalemme
Già nei primi secoli dell’era cristiana, i fedeli sentivano il bisogno di andare, di toccare, di vedere i luoghi dove Dio aveva parlato, dove i martiri avevano testimoniato la fede con il sangue. Era il tempo delle catacombe, delle basiliche dei martiri, delle tombe dei santi. E così, dalle regioni più lontane del Mediterraneo, si partiva per Roma, verso le tombe di Pietro e Paolo, o per la Terrasanta, là dove Cristo aveva camminato, predicato, sofferto, vinto la morte. Lo racconta anche il vescovo Eusebio di Cesarea (detto il “padre della storia ecclesiastica”: fin dal II secolo, i cristiani partivano verso Gerusalemme, verso quel Santo Sepolcro che ancora oggi parla di speranza e resurrezione. Ma l’anima cercava anche altri santuari, quelli dove l’angelo aveva lasciato il segno. Così nasce il culto micaelico: la grotta a Monte Sant’Angelo sul Gargano, la maestosa Sacra di San Michele in Val di Susa, e poi Mont Saint-Michel in Normandia.
E poi arrivò Santiago de Compostela, con la tomba dell’apostolo Giacomo: meta, simbolo, richiamo per milioni di persone. Cammino di fede, ma anche di riconquista, in un’epoca in cui la fede era anche resistenza.
Fede incarnata
Il pellegrinaggio è dunque l’espressione più pura della fede incarnata: non si crede solo con la mente, ma con il corpo che cammina, con le ginocchia che si piegano, con gli occhi che piangono davanti a una reliquia o ad un altare lontano. Si parte per toccare una verità che si vuole reale, più forte di ogni dubbio.
Non si tratta di un viaggio comodo ma di un viaggio necessario. Perché certe risposte non si trovano sui libri: si trovano lungo la strada, nei silenzi tra un passo e l’altro, nell’incontro con l’altro pellegrino, in una preghiera sussurrata davanti a una pietra millenaria.
Se ieri il pellegrino si affidava alle stelle e ai conventi, oggi viaggia con una guida, con una app, col GPS. Ma il cuore resta lo stesso: ha bisogno di incontrare Dio, o almeno di cercarlo. E così, ancora oggi, si parte e si cammina. Non per vedere luoghi, ma per confermare la propria fede o per credere di nuovo.
Viaggi affini, differenti visioni
Spesso usiamo le parole pellegrinaggio o turismo religioso come sinonimi, ma così non è. Il pellegrino parte per cercare Dio, o almeno una risposta. Il cuore batte più del GPS, e ogni passo è un dialogo interiore. Si parte per incontrare. Il pellegrino non cerca il monumento, cerca il Mistero. Un cammino che più che portare da qualche parte, riporta a sé stessi. Nel pellegrinaggio, anche l’economia si fa umana: accoglienza, ospitalità, condivisione. Si dorme nelle foresterie, si mangia con semplicità, si incontra il prossimo. Un viaggio dove non si consuma, ma si costruiscono relazioni; in cui finisce il sentiero, ma il cammino interiore continua. Il turista religioso, invece, è mosso da curiosità, interesse culturale, desiderio di arricchimento spirituale. Visita luoghi sacri per capirne la storia, scopre itinerari tra fede e tradizione. Il suo sguardo è più esterno, ma non per questo meno valido. Si potrebbe dire che il pellegrino e il padre del turista religioso, con la differenza che il primo cammina per bisogno d’anima, il secondo per sete di conoscenza.
Secondo il Centro Studi del Touring Club Italiano e l’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), nel nostro Paese il turismo religioso genera un indotto economico di circa 2,5 miliardi di euro all’anno. Questo include spese per ospitalità, ristorazione, trasporti, acquisti nei luoghi sacri, guide turistiche, e prodotti tipici locali. In alcune realtà locali, come Assisi, Loreto, San Giovanni Rotondo o Pompei, l’incidenza del turismo religioso sull’economia locale può superare il 50% del PIL comunale.
I numeri dei cammini
Dietro ogni candela accesa, ogni passo in salita, ogni panchina su cui un pellegrino si riposa, ci sono anche numeri che raccontano un altro aspetto di questa realtà. Secondo il Rapporto 2024 dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Turismo della CEI, il turismo religioso in Italia coinvolge ogni anno tra i 5 e i 6 milioni di visitatori. E che sono oltre 1.500 i santuari sparsi sul territorio nazionale, veri e propri fari accesi tra le colline, le montagne, le periferie. Secondo il Centro Studi del Touring Club Italiano ogni anno, in questi luoghi di culto, si registrano circa 30 milioni di visite. San Giovanni Rotondo, patria spirituale di Padre Pio, accoglie circa 1,5 milioni di pellegrini l’anno. Assisi, casa di san Francesco, supera il milione di fedeli, così come Loreto, che – insieme a Pompei e Roma – fa parte del cuore pulsante del pellegrinaggio italiano. Ma non è solo turismo “di casa nostra”: oltre il 40% dei pellegrini in Italia proviene dall’estero – soprattutto da Polonia, Francia, Spagna e Stati Uniti – con Roma e il Vaticano in cima alla lista delle mete predilette. Secondo l’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), più del 60% dei pellegrini stranieri sceglie la Città Eterna come primo approdo spirituale. Con il Giubileo del 2025, secondo le stime del Comune capitolino e del Vaticano, si prevede un vero e proprio “esodo della fede”: oltre 30 milioni di pellegrini solo a Roma.
Non sono solo le grandi basiliche a chiamare i fedeli. I cammini spirituali – come la Via Francigena, il Cammino di San Francesco, il Cammino Materano e quello di San Benedetto – registrano un boom senza precedenti. Solo la Francigena, nel 2023, ha contato circa 80 mila camminatori.
Tratto dal mensile "Frate Indovino", n.7, 2025