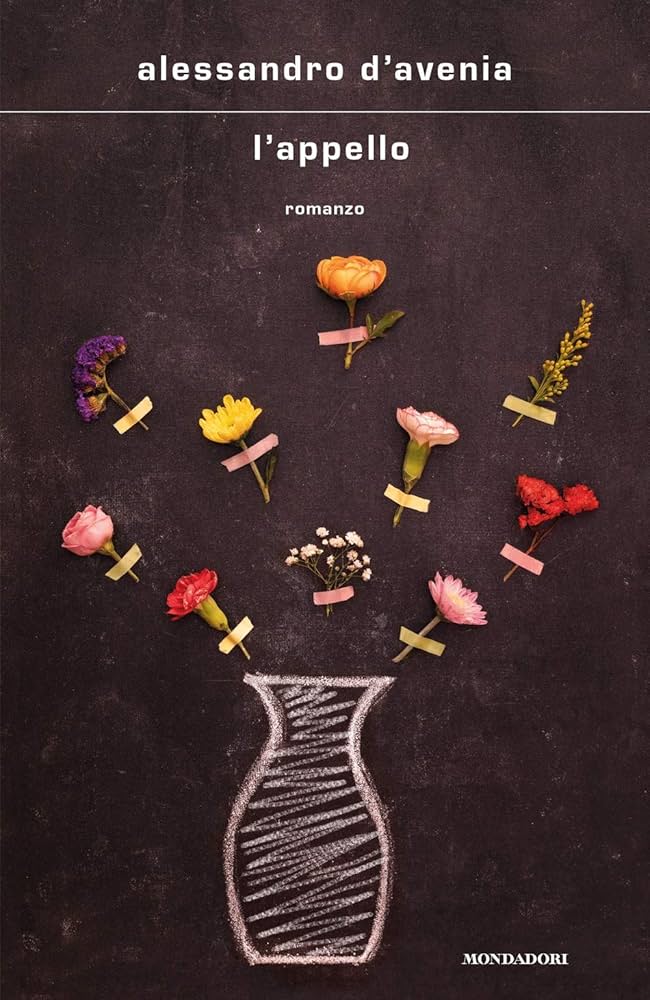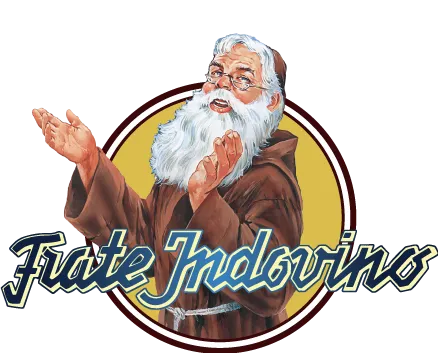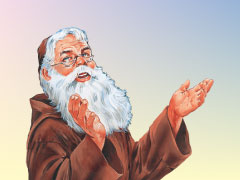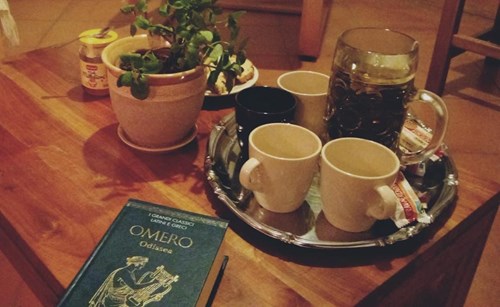Alessandro D’Avenia, scrittore e insegnante, nel romanzo L’appello racconta la scuola attraverso la figura di Omero, professore cieco che torna in aula per guidare dieci studenti “difficili”. Il romanzo, che fonde diario, epistolario e romanzo di formazione, segue l’anno scolastico da settembre a settembre, alternando narrazione e riflessione. Omero, toccando i volti dei suoi alunni, cerca la loro interiorità, opponendosi alla logica impersonale dei social e dell’autorità imposta.
La riforma scolastica immaginata dai suoi studenti si fonda su due principi: gioia e relazione. «Nutre la mente soltanto ciò che le dà gioia, e la vita cresce soltanto grazie a relazioni buone». L’obbligo scolastico viene criticato come ostacolo alla libertà e alla responsabilità. Il maestro, secondo D’Avenia, non trasmette solo sapere, ma chiama per nome, riconosce e accompagna. L’appello diventa così il momento più importante della giornata: pronunciare il nome di ogni allievo è un atto di riconoscimento e di amore.
La scuola ideale non ha cattedre ma una tavola rotonda, dove si cerca insieme la verità. L’insegnamento è vocazione, non imposizione. Il maestro non impone contenuti, ma favorisce la fioritura dell’identità dell’allievo. «Le idee sono nelle loro teste, non ce le ho messe io», afferma Omero. La relazione educativa è fondata sulla libertà, non sull’obbligo.
Tra le proposte di riforma, spiccano tre figure: il maestro di lettura, di grafia e di latino, simboli della capacità di ascolto, del lavoro manuale e della logica. D’Avenia difende la lettura dei classici come mezzo per raccogliersi e conoscersi, non come fine scolastico. La grafia, più che un vezzo, è un richiamo alla trasmissione culturale e artigianale, oggi trascurata.
Un ruolo centrale è attribuito anche ai genitori, considerati primi educatori. La qualità della relazione tra loro incide profondamente sulla vita interiore dei figli. In questo contesto emerge il cuore della visione daveniana: la ricerca del padre. La scuola è vista come luogo in cui i figli attendono il ritorno dei padri, non come autorità assolute, ma come testimoni capaci di aprire mondi.
La morte di Omero suggella il passaggio di testimone: la scuola vive dove c’è relazione, libertà e desiderio di senso. Il maestro è colui che chiama per nome, anche chi si presenta come una vite storta, e così facendo permette alla vita di manifestarsi.
Vorrei concludere questa recensione con alcune parole dal diario di Alexander Schmemann (1921-1983): «Nessuna annotazione (libri, articoli) trattiene mai del tutto quello che ti si spalanca davanti mentre parli. È il primato, ontologico, dell’annuncio del cristianesimo. Cristo non scriveva. Tutti gli scritti (la Bibbia ecc.) non fanno che registrare un’esperienza. E non un’esperienza individuale ma sovraindividuale, cosmica appunto, ecclesiale, “escatologica”. È l’errore di chi pensa che l’educazione si svolga a livello di idee. No, è sempre un’esperienza che si comunica… La gente non si convince con argomentazioni. Si “infiamma” oppure no» (30 marzo 1973).
Mi rendo conto della severità del giudizio di questo teologo ortodosso sull’utilità dei libri (la “libridine”, invece, per D’Avenia è una pulsione imprescindibile e trasformante). Ma vorrei restare su questo “fuoco sacro”, che rende un maestro credibile. Lo stesso che resta nei discepoli di Emmaus come un ardore del cuore, una memoria gioiosa dell’ora di lezione perché, come si diceva all’inizio, rallegrarsi è il principio di una conoscenza duratura. Il divampare di questo fuoco nel discepolo può darsi solo in una relazione libera, non obbligante né obbligata. Solo la libertà fa la persona. A questa legge non scritta obbedisce anche la genialità di ogni essere umano, ovvero la sua relazione creativa con la vita. Ma perché questa genialità avvenga, è necessario che un altro, un maestro, la chiami. E chiami la persona per come è, con il suo nome, anche se si presenta come una vite storta. La vita, così, può essere ricreata, accogliendola totalmente, consentendole di manifestarsi, di uscire dall’anonimato.