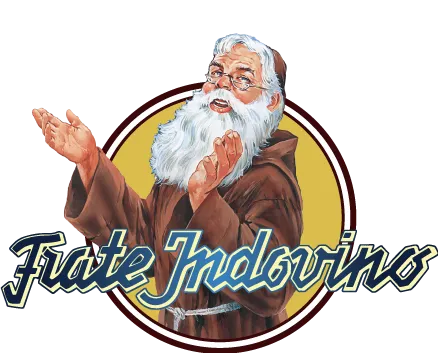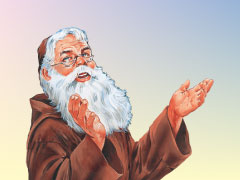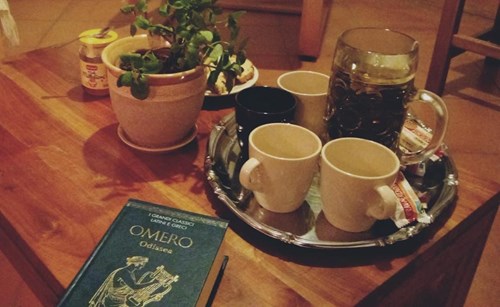«Abbiate la massima cura di queste cose: salute mentale, salute fisica e, soprattutto, affetti. Tutto il resto è superficiale. La mia malattia non mi ha mai fermato dal vivere a pieno, e voglio che sia così anche per voi, in ogni ostacolo che dovrete affrontare». Queste le parole-testamento di Giovanni Iotti, 19 anni, che lo scorso 30 giugno - il 28 giugno aveva sostenuto il suo esame di maturità - è mancato dopo una grave malattia, che lo accompagnava dal 2021, con dolore sì, ma pieno di vita.
Le parole di Giovanni non sono un monito per nessuno, ma un fascio di luce sulla realtà della vita, di cui fare tesoro. Quando accogli la vita - e, nel suo caso, la fede è stata una vera dinamo - la vita si fa piena. Se pure non fosse stato 100 il risultato finale del suo esame di Stato, in lui si è compiuto il 100 per 1 e la vita eterna che il Signore promette nel Vangelo. Questo è quello che si desidera riconosciuto alla nostra maturità: il contenuto di vita che abbiamo maturato, dove la nostra vita si è accesa perché si slanci nell’indicativo futuro.
Per Alessandro D’Avenia, la scelta di alcuni studenti di non sostenere il colloquio orale agli ultimi esami di maturità, non è stato «un campanello d’allarme ma una conferma» di qualcosa che aveva già raccontato nel romanzo L’appello (2020).
Secondo D’Avenia «i dati erano già evidenti, basta stare in classe nel sistema della scuola di oggi per capire che cosa questi ragazzi ci stanno chiedendo». Per il “prof 2.0” non si tratta di schierarsi con gli uni o con gli altri, avallare una rivoluzione naïve di studenti sfaccendati o usare il pugno duro dell’autorità, ma «svincolarsi dalla dialettica professori contro studenti, autorità contro insubordinazione », perché sarebbe una chiave di lettura erronea. Quello che è andato in scena, secondo D’Avenia, è «l’eterno contrasto tra la vita e il mondo, la vita di ciascuno che lotta per venire alla luce e il mondo che ha le sue logiche impostate su ciò che è efficiente». Quali che siano state le ragioni più o meno valide, più o meno “spiegate” dei ragazzi che si sono esposti a questo gesto, quello che viene registrato dal commento dell’autore è che oggi «la scuola è il posto in cui si quantifica l’umano nell’uomo attraverso le sue performance, in continuità con la cultura dominante, ovvero quella del risultato», che non può che essere uno sguardo parziale sulla vita. E la vita - che pure non risparmia a nessuno prove anche più dure - non si lascia “costringere” in uno schema valutativo e ogni tanto “si ribella”.
Il limite di questo sistema basato sui voti e finalizzato a quantificare una performance, è quello di identificare la persona in quel numero e per lo studente di identificarsi con quel numero. Sappiamo che non è certo così e che «i voti fanno parte di un percorso educativo che, se dichiarato fin dall’inizio, ha una funzione positiva ineliminabile (hai fatto bene, male… non sei fatto bene o male)». Per Alessandro D’Avenia, il gesto di questi ragazzi traduce una provocazione: «Datemi il minimo, non mi interessa, la vita è di più». Non esprime tanto un contrasto con gli insegnanti, ma quella che D’Avenia chiama «la ribellione dei corpi» a un sistema che si perde l’unicità della vita di ogni persona. Ecco che allora «non stupisce che il sistema reagisca inasprendo la regola, perché come ogni sistema deve tutelarsi, altrimenti viene esautorato». La domanda allora che il professore si pone è: «La scuola riesce a intercettare la vita nella sua pienezza, o questo sistema sta mostrando le crepe e non è più sostenibile?» È un sistema che mortifica anche l’insegnante, che diventa un valutatore (anzi, un “commissario”!). Per D’Avenia, invece, è chiarissimo cosa la scuola debba essere, «una bottega di vocazioni, dove e quando tu incontri, attraverso le persone, dove il mondo non muore».